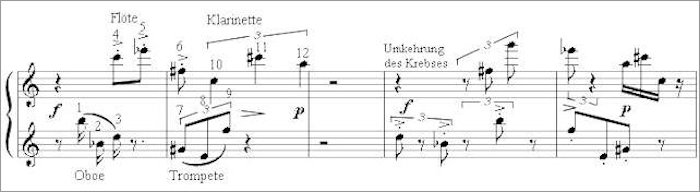Arnold Schönberg
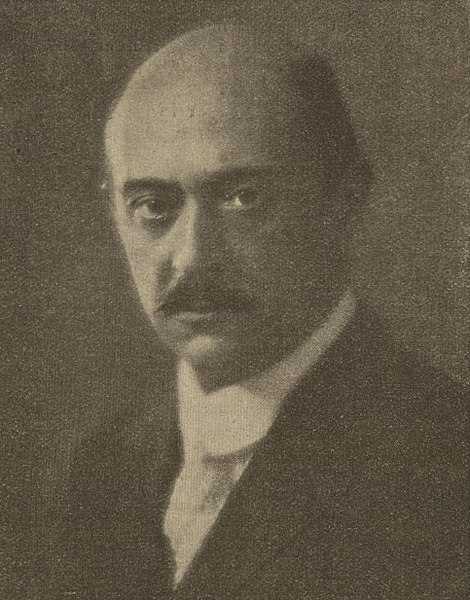 Arnold Schönberg (1874-1951).
in una foto del 1928
Arnold Schönberg (1874-1951).
in una foto del 1928
foto:
Georg Fayer
Le prime influenze musicali:
Arnold Schönberg nasce a Vienna il 13 settembre
1874. Fa parte di una famiglia piccolo borghese dalle modeste condizioni
economiche. A causa di ciò abbandona gli studi liceali molto presto e
coltiva la sua formazione musicale in buona sostanza da autodidatta. Il suo
apprendistato è vario e disordinato, tuttavia scambia esperienze e riceve
lezioni di armonia e contrappunto da importanti musicofili tra cui Alexander
von Zemlinsky. Quest’ultimo lo guida verso l’adesione alle avanguardie
tedesche. Nel 1901 va a Berlino dove insegna al conservatorio. L’anno
successivo fa ritorno a Vienna e nel 1910 diventa professore di composizione
presso l’ Akademie für Tonkunst. Peregrinerà fra
Vienna e Berlino fino al
1925, anno in cui si stabilirà nella capitale tedesca ottenendo anche qui
una cattedra di composizione presso la Kunstakademie.
Il musicista austriaco muove i suoi primi passi attingendo a
Wagner,
Mahler
e Brahms. Da sempre estraneo alle polemiche fra brahmsiani e wagneriani,
Schönberg coglie da questi grandi maestri un’originale influenza
riscontrabile nei lavori come il Quartetto in re maggiore, i Lieder op.1,
op.2, e op.3, il poema sinfonico per sestetto d’archi
Verklärte Nacht (La
notte trasfigurata) del 1899 e quello per grande orchestra
Pelleas e
Melisande del 1903 oltre ai grandiosi Gurrelieder. Già da qui si nota come
sia in corso un’introduttiva dissoluzione tonale.
L'adesione al movimento espressionista:
Il Novecento si apre con un’enorme ansia di soverchiare i precedenti
atteggiamenti estetici e morali; l’intellettuale vuole letteralmente
raschiare dalla società la falsa rassicurazione del conformismo borghese,
assorbe le tensioni in circolazione e le fa proprie convertendole in azione.
Delle numerose correnti quella più decisiva per la musica è senz’altro
l’Espressionismo. Schönberg aderisce a questo desiderio di svincolarsi dalla
realtà esteriore, traducendo in suoni quello che Kandinskij,
Kokoschka, Klee
fanno in arte e Zweig,
Kafka e Kaiser in letteratura.
Arnold vuole avviare un’estetica più personale sganciata da schemi
prefissati e promuove una reinterpretazione dei modelli classici nella
Kammersymphonie op.9, nei due
Quartetti in re minore op. 7 nonché nei
Tre pezzi op.11 per pianoforte.
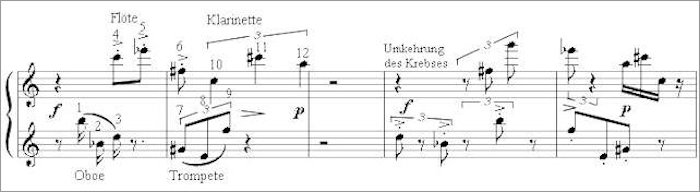 Un estratto dallo spartito della Serenate op.24
Un estratto dallo spartito della Serenate op.24
La rottura con l'armonia classica:
Stringe legami con molti esponenti delle avanguardie artistiche dell’epoca,
tra cui il già citato Vassilij Kandiskij e
Gustav Mahler. Compone nel 1908
quindici liriche op.15 tratte da
Das Buch der Hängenden Gärten
(Il libro dei
giardini pensili), un testo del poeta tedesco Stefan George e nel 1912
aderisce totalmente al movimento espressionista unendosi ai fondatori del
gruppo Der blaue Reiter (Il cavaliere azzurro). Questo segna la definitiva
rottura di Schönberg con le convenzioni del sistema tonale. Prima della
prima guerra mondiale nascono i capolavori come i Cinque pezzi per orchestra op. 16,
Die glückliche Hand op. 18 (La mano felice), Sei piccoli
pezzi per
pianoforte op. 19 fino al famigerato Pierrot Lunaire op. 21 nel 1912,
quest’ultimo innovativo per l’uso dello Sprechgesang, il canto parlato, in
aperto contrasto con quello tradizionale. Nel 1911 convoglia le sue idee sul
linguaggio armonico nell’Harmonielehre, il Manuale d’armonia.
Nel primo dopoguerra il compositore austriaco continua il suo percorso e
trasforma l’atonalità nel cosiddetto metodo dodecafonico, ovvero il più
radicale tra i nuovi linguaggi che i compositori fino ad allora abbiano mai
tentato. L’atonalismo nega la gerarchia e la relazione nell’ordine dei
suoni, fa esplodere le regole rigide di un sistema ormai considerato
immutabile e indiscutibile. Schönberg individua un nuovo ordine che lui
definisce “di composizione con dodici note in relazione solo fra loro”.
Con
la dodecafonia il musicista vuole collocare su un medesimo piano tutti i
suoni della scala cromatica e ne utilizza una specifica successione chiamata
serie. La serie originaria di dodici suoni può essere variata in diversi
modi: per inversione, ovvero in cui gli intervalli fra le note si susseguono
in modo contrario, per retrogradazione dove le note sono collocate
dall’ultima alla prima e l’unione delle due cose, cioè l’inversione
retrograda. Il maestro crea un procedimento vero e proprio basato sull’uso
di serie di suoni che comprendono tutte e dodici le altezze del sistema
temperato.
Il primo esempio musicale è nel Walzer dai
5 Klavierstücke op.
23. Man mano la tecnica è stata perfezionata e fra le più importanti opere
dodecafoniche possiamo ricordare la Serenate op. 24 per baritono e complesso
strumentale, la Suite op. 25 per pianoforte, il
Quintetto per fiati op. 26,
la Suite op. 29 per complesso da camera e le
Variazioni per orchestra op. 31
del 1928 in cui vengono usate tutte le forme della serie. Schönberg, oltre
che teorico, si occupa anche di didattica musicale e con i suoi famosi
allievi, Alban Berg e
Anton von Webern, costituisce la
Scuola di Vienna,
sede e punto di riferimento per i musicisti delle nuove generazioni e per
gli sperimentalismi. Negli anni Trenta compone per il teatro: con il
Moses
und Aron rimasto incompiuto a causa dell’esilio per motivi razziali del
maestro voluto dai nazisti, sintetizza ancora una volta la sua estetica
della musica; l’intera opera è costruita appunto su un’unica serie
dodecafonica.
Schönberg in esilio tra Francia e Stati Uniti:
Con l’avvento del nazismo a Schönberg fu revocata la cattedra
presso l’ Accademia statale di musica di Berlino e fu costretto a spostarsi
a Parigi prima, poi via via in altre città fino a
Los Angeles dove si
stabilisce fino alla morte. Le opere che compone dal 1935 alla fine
possiedono tutte una forte denuncia sociale e politica come la
Cantata
ebraica Kol Nidre op. 39, l’Ode to Napoleon op. 41 del 1942, e soprattutto
A survival from Warsaw (Un sopravvissuto di Varsavia) del 1947 per ricordare
le barbarie tedesche avvenute nella capitale polacca.
Negli Stati Uniti il compositore austriaco si concentra sul settore vocale,
ma alcuni esempi in ambito strumentale sono rimasti maggiormente conosciuti
tra cui il Concerto per violino e orchestra op. 36, il
Concerto per
pianoforte e orchestra op. 42 e due opere da camera: il Quartetto op. 37 e
il Trio per archi op. 45.
 La tomba di Arnold Schönberg a Vienna (Zentralfriedhof)
La tomba di Arnold Schönberg a Vienna (Zentralfriedhof)
foto:
Daderot
Muore il
13 luglio 1951 nella città californiana
dopo aver stravolto il mondo musicale con la sua individualità creativa e il
suo temperamento intuitivo sullo sfondo di uno scenario culturale intricato.
Grazie a lui la musica si è emancipata dalla tonalità classica dischiudendo
le porte ad un’inedita dimensione armonica e cromatica; è a pieno titolo il
legislatore della dodecafonia.
testo:
Daniele Brina
Altri compositari austriaci di musica classica:
Potrebbero interessarti anche:
© 2025 Wolfgang Pruscha
Termini e condizioni di utilizzo del sito